Un archeologo da Lamon agli Stati Uniti. «Mi sono formato scavando a San Donato»
Paolo Forlin riceverà proprio nel suo paese di origine il premio come bellunese che si è distinto nel mondo
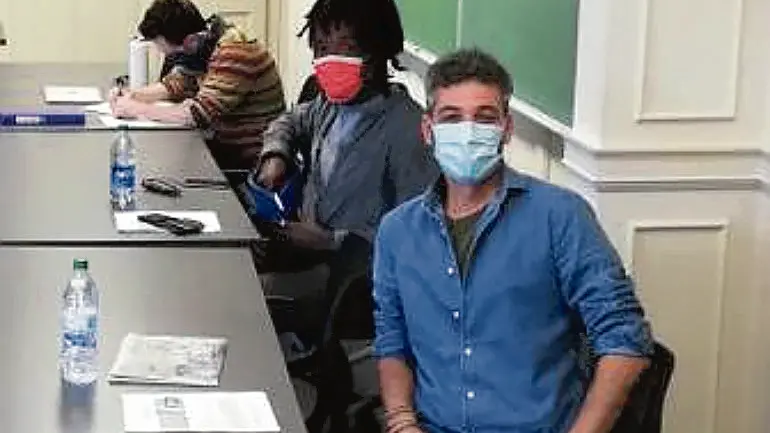
Paolo Forlin alla Northwestern University
LAMON. Archeologo appassionato di storia medievale e di terremoti, Paolo Forlin, classe 1978, è uno di protagonisti della cerimonia di sabato mattina
Articolo Premium
Questo articolo è riservato agli abbonati.
Accedi con username e password se hai già un abbonamento.
Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop
Non hai un account? Registrati ora.
Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi
Leggi anche
Video








